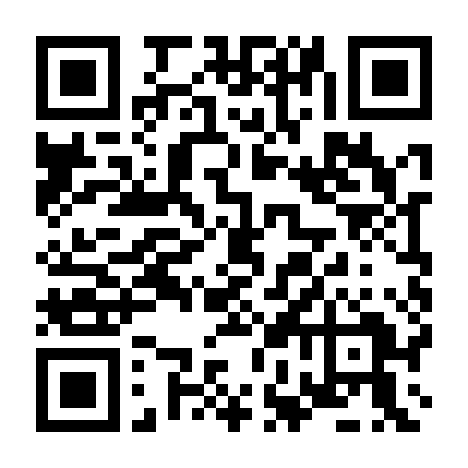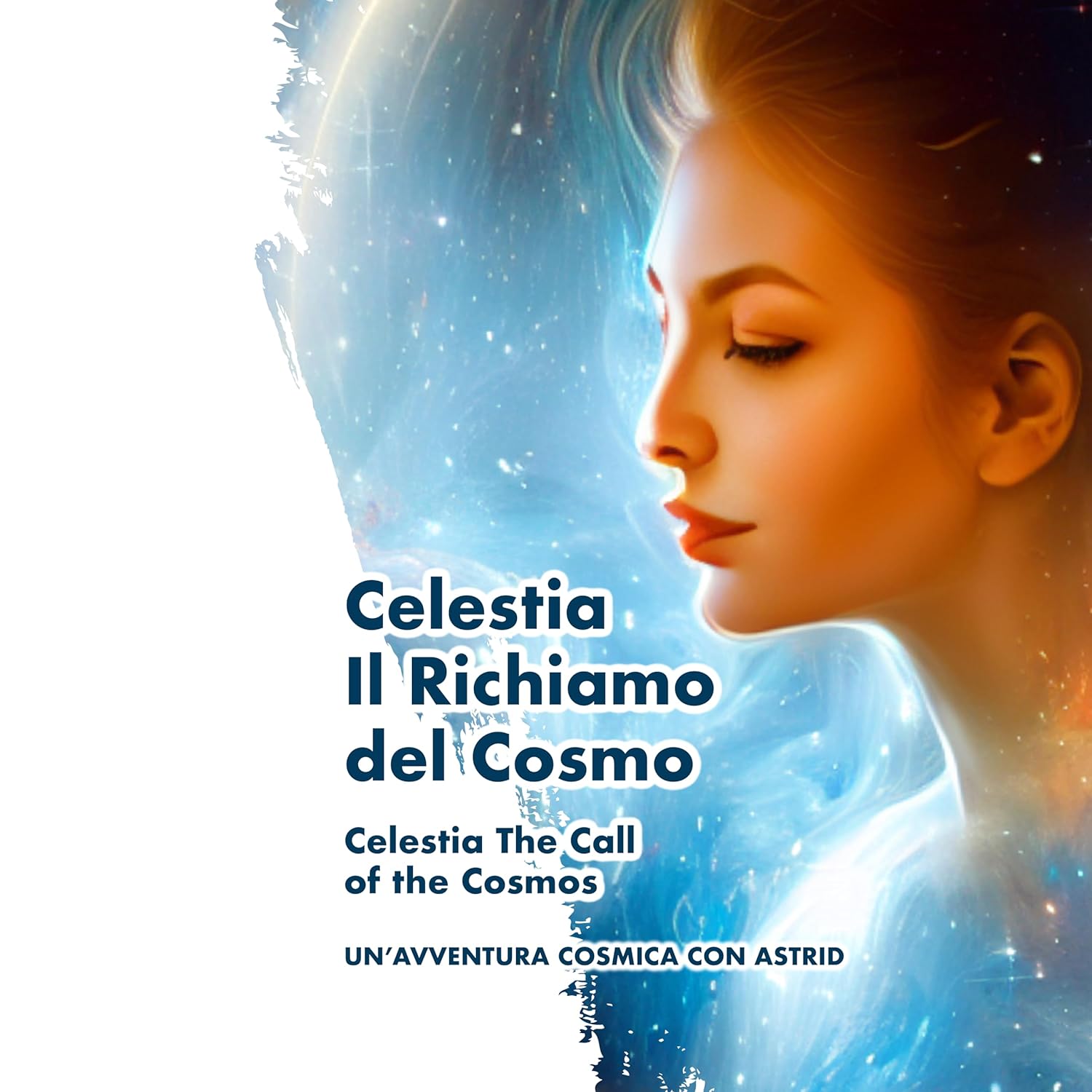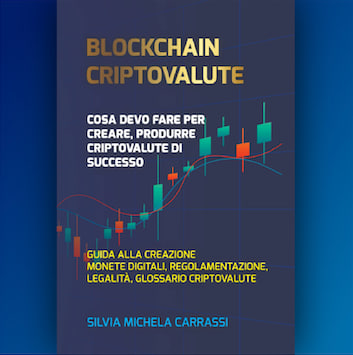parole 727 3 minuti
0
0